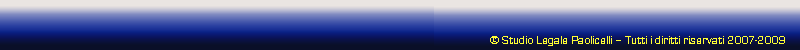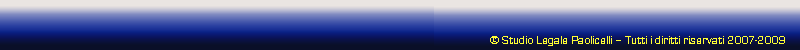|
La Disciplina
Dei Reati Informatici Tra Regolamentazione Comunitaria e
Legislazione Italiana
Qualcuno ha definito i reati informatici come l'effetto negativo
dell'evoluzione tecnologica moderna.
Io preferisco definire questo fenomeno come una tappa imprescindibile
della storia dell'uomo. È comunemente risaputo quanto le scienze moderne
si diano da fare per realizzare modelli previsionali dei più svariati
accadimenti scientifici e sociali. Nel nostro caso, circa all'inizio del
secolo scorso si era ipotizzato un percorso relativo alla criminalità che
ricostruiva un probabile scenario evolutivo. La criminalità di strada o
microcriminalità si sarebbe estinta lasciando spazio ai reati di matrice
economica, che avrebbero fatto uso degli strumenti che le nuove scoperte
scientifiche avrebbero messo a disposizione a breve tempo.
Effettivamente la previsione non era del tutto errata, se non per alcuni
aspetti fondamentali che non sono stati valutati con il giusto metro di
misura.
Se è pur vero che lo sviluppo dei paesi industrializzati ha favorito
l'accesso a servizi e beni sempre più avanzati tecnologicamente, è anche
vero che il divario tra paesi ricchi e paesi poveri è andato sempre più
crescendo. Carl Marx, in numerosi suoi saggi, ha sempre attribuito la
difficoltà di livellamento in questo senso al fatto che non c'era – ed io
aggiungo non c'è – la volontà di migliorare la condizione dei paesi
cosiddetti del terzo mondo. "L'effetto tecnologico" ha portato i suoi
frutti dove effettivamente è riuscito a radicarsi e cioè nei paesi
occidentali, portando con se due grandi conseguenze: 1. consentire
l'utilizzo dello strumento informatico anche alla gente "comune"; 2. non
prevedere strumenti di prevenzione e repressione di un utilizzo scorretto
di tali tecnologie.
Pertanto, tornando alla dichiarazione fatta inizialmente, ossia che i
reati informatici sono l'effetto negativo dell'evoluzione tecnologica si
potrebbe rispondere che la criminalità in genere è l'effetto negativo
dell'evoluzione dell'uomo!
È chiaro che la fruibilità di certi strumenti da parte di tutti gli
appartenenti alle società moderne non avrebbe potuto escludere la
partecipazione di alcuni soggetti piuttosto che di altri, pertanto risulta
evidente come la criminalità informatica sia caratteristica intrinseca non
dell'evoluzione tecnologica ma della presenza necessaria dell'uomo. Il
computer o qualunque altro strumento informatico seppur "animato" da
software di intelligenza artificiale non opera seguendo i propri istinti o
la brama di potere e denaro, ma pone in essere una serie di operazioni
rispondenti alla volontà di un operatore…umano!
Il primo effetto che ha seguito la radicale diffusione degli strumenti
informatici e/o telematici è stato proprio quello di abbattere le teorie
evoluzionistiche di criminalità. Non solo la criminalità innanzi definita
"di strada" è aumentata – anche in relazione alle tipologie di fattispecie
– ma addirittura è stata affiancata da tutta una serie di reati che in
questa sede classifichiamo come reati informatici o crimini informatici.
Pertanto si sono venute a creare nuove fattispecie concrete che trovavano
poco spazio e comprensione da parte dei magistrati, prima, dei
legislatori, poi.
E le difficoltà sono andate via via aumentando a causa della facilità con
la quale, gli utenti delle reti pubbliche quali internet, riuscivano ad
accedere a informazioni, contenuti, software che cominciavano ad occupare
gigabyte di memoria all'interno di server non meglio identificati né
normativamente controllati.
L'analogia, è stato il primo rimedio a disposizione dei governi per venire
incontro alle esigenze di un potere, quello della magistratura, che più
potere non aveva dinanzi a reati che ancora non trovavano un'esatta
collocazione.
L'utilizzo dei sistemi elettronici di conservazione dei dati risalgono
sino agli anni '50, se non prima, ma dati i costi esosi necessari per la
realizzazione di impianti adibiti a tale scopo, ben pochi erano gli enti
che potevano dotarsene. Pertanto le uniche norme che in qualche modo,
seppur arcaico tutelavano il bene informatico, riguardavano condotte quali
l'attentato ad impianti di elaborazione dati (vecchia formulazione
dell'art. 420 c.p. introdotto dalla L. 191/78).
Con la diffusione di mezzi di uso comune sempre più tecnologicamente
avanzati, si è assistito alla diversificazione ed ampliamento delle
condotte di cui ci stiamo occupando; e così a partire dagli anni '90 il
legislatore italiano avviava la sua "lotta" alla criminalità informatica
con una serie di interventi eterogenei che cominciavano a circoscrivere
tutte quelle fattispecie orfane di norme fino a giungere nel 1992 con la
legge n. 518 ad una prima individuazione di "pirateria informatica" come
condotta antigiuridica da scongiurare.
Il primo vero intervento in materia si ebbe solamente nel 1993 quando con
la L.n. 547 che introdusse definitivamente, nel diritto penale italiano,
un elenco di fattispecie sino ad allora solo abbozzate, in grado di
ricomprendere quelle che si ritenevano essere le moderne condotte
antigiuridiche.
Volendo riunire in via esemplificativa tutto quanto previsto dalle norme
ivi comprese, possiamo raggruppare i beni tutelati sotto le categorie
seguenti:
Truffe informatiche;
Protezione dei dati personali;
Danneggiamenti;
Manomissioni.
Insomma da una rilettura delle norme relative alla protezione dei beni
comunemente riconosciuti dalla società civile, furono coniate norme che
analogicamente andarono a tutelare questi "beni" informatici che ben
pochi, in realtà, avevano realmente individuato. Aggiungerei che ad oggi
numerosi operatori del diritto quando vengono posti dinanzi a tematiche
riguardanti i beni informatici, tendono ad assumere atteggiamenti quasi
repulsivi o comunque atti a valutare gli stessi alla stregua di beni
materiali comuni.
Evitando di soffermarci troppo tempo sull'attività legislativa italiana, è
necessario volgere l'attenzione a un importante provvedimento posto in
essere dall'Unione Europea ossia la tanto risonante Convenzione del
Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica.
Quale primo accordo internazionale riguardante i reati commessi a mezzo
internet o altre vie informatiche, questo provvedimento si caratterizza
per l'ampiezza delle fattispecie ivi previste e comunemente catalogate
sotto la voce di "computer crimes". Questo effetto è stato ottenuto con
l'estensione dei reati informatici a tutte quelle condotte che utilizzano
anche in modalità non primarie strumenti informatici o che comunque
possono essere individuate attraverso l'utilizzo degli stessi.
Ben quattro anni di lavori condotti da un Comitato di esperti selezionati
all'uopo al quale è stato offerto l'appoggio anche di nazioni non facenti
parte dell'unione europea.
L'importanza del documento in esame è proprio quella relativa alle
finalità dallo stesso perseguito; ossia l'unificazione, il riavvicinamento
– non solo normativo – degli Stati membri, attraverso l'adozione di una
legislazione adeguata e comune
La Convenzione è entrata in vigore il 1° luglio 2004 e l'Italia ha
effettuato la ratifica della Convenzione con la legge 18 marzo 2008, n.
48.
Al suo interno sono racchiusi ben 46 articoli raggruppati in quattro
differenti capitoli:
Capitolo I, formato da un unico articolo raggruppa la terminologia
utilizzata. Particolare attenzione, in proposito, dev'essere prestata alla
definizione di "sistema informatico" identificato come tutte le
strumentazioni che, dotate di software, possono sviluppare autonomamente
dei dati. Va da sé che una tale definizione finisce per ricomprendere
un'infinità di congegni elettronici attualmente in uso alla gente comune.
L'effetto di questa norma è di enorme portata, considerata la tendenza
delle case produttrici di apparecchi elettronici, a realizzare sempre più
sistemi integrati che aggiungono alle funzioni di base di un determinato
apparecchio possibilità di calcolo ed elaborazione dati pressoché
infinite.
Capitolo II superata la parte dedicata alla delimitazione della
portata della Convenzione, il contenuto orienta la sua attenzione verso i
risvolti della stessa in ambito normativo rispetto alla competenza, la
natura dei reati e le norme procedurali relative in ambito nazionale.
Dal punto di vista sostanziale la disciplina dettata dalla Convenzione non
si discosta eccessivamente dal contenuto normativo italiano. A ben vedere
i beni giuridici tutelati non possono variare nel tempo in quanto
risultano essere la digitalizzazione di beni da sempre presenti in capo ai
membri di ciascuna società civile.
Naturalmente senza che tale elencazione si tramuti in una limitazione per
la "creatività" dei legislatori interni a ciascun Membro dell'Unione.
Dal punto di vista procedurale invece le prese di posizione sono
maggiormente intensificate in vista di una più rapida soluzione dei casi
che abbiano a oggetto reati informatici; in tal senso l'innovazione
tecnologica deve essere utilizzata per la conservazione, trasmissione,
utilizzazione di prove, dati e altre informazione in formato digitale.
Capitolo III, forse il più importante in ordine alle finalità di
integrazione perseguite dalla Convenzione, fa riferimento ai provvedimenti
relativi all'estradizione e alla assistenza tra le Parti.
I principi fondamentali sanciti dall'articolo 23 fissano una volta per
tutte la portata del vero spirito di unificazione europea non solo in
senso economico. Si rende necessario, secondo la Convenzione, cooperare
con gli altri membri per la repressione e prevenzione di tutte quelle
condotte che si riconoscono nella definizione di reato informatico
contenuta sia nella Convenzione che in altri accordi a carattere
internazionale.
L'incentivo all'uniformità delle normative interne viene poi suggerito dai
successivi artt. 24 con la previsione dell'istituto dell'estradizione ai
soli reati che risultano essere puniti dai Paesi interessati e art. 25 con
la determinazione dei principi di assistenza reciproca delle Parti sotto
l'aspetto delle investigazioni criminali.
Inoltre la Convenzione prevede la realizzazione di un sistema telematico
uniformato che metta in comunicazione le autorità dei Paesi aderenti al
fine di rendere più celeri le richieste di assistenza e la trasmissione
dei relativi dati.
Anche in materia di crimini informatici viene inoltre suggerito ai Paesi
aderenti di conciliare le controversie con modalità pacifiche quali il
Comitato Europeo dei Problemi Criminali, un collegio arbitrale o Corte
Internazionale di Giustizia.
La denuncia della Convenzione avrà effetto dal primo giorno del mese
successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dal ricevimento della
notifica da parte del Segretario generale del Consiglio d'Europa.
Con la ratifica effettuata dal governo italiano, è stato posto un accento
marcato sull'intenzione preventiva e repressiva di tali fattispecie
criminali. All'inizio del secolo scorso nulla o quasi era stato posto in
essere al fine di prevenire quei fenomeni di criminalità cui si accennava
innanzi. Nel nuovo millennio molto probabilmente si tenterà di non
ripetere gli errori del passato.
Un unico e crescente dubbio sembra però ottenebrare l'iniziativa
dell'Unione Europea: la rete internet non è prerogativa dei Paesi aderenti
alla Convenzione, pertanto, come è accaduto fino ad oggi in materia di
pedopornografia on-line, ossia il mantenimento dei contenuti all'interno
di server ubicati in "zone franche", il grande lavoro di coordinamento e
cooperazione potrebbe andar perduto proprio a causa di Paesi che non
intendono aderire alla Convenzione, né stipulare accordi internazionali
con le medesime finalità collaborative.
Una pietra miliare è stata posta lungo il cammino evolutivo delle moderne
società e che non può essere ignorato.
Tuttavia si rende necessario un intervento molto più radicale.
L'alfabetizzazione del cittadino, l'educazione delle nuove e vecchie
generazioni al concetto di bene digitale e non virtuale.
L'erronea convinzione che ciò che attiene all'informatica sia tutta realtà
virtuale dev'essere depennata definitivamente. Per "virtuale" s'intende
simulazione, immaginazione, tutto ad eccezione del reale. Ma i beni
informatici sono reali benché digitalizzati. Se così non fosse la norma
perderebbe tutta la sua valenza andando a tutelare un bene che non esiste
nel mondo reale.
Il concetto di bene virtuale contribuisce a sottovalutare la portata delle
proprie azioni in relazione all'uso di un computer, che già di per sé è
reso agevole dall'assenza di un interlocutore umano che indichi di volta
in volta la commissione di condotte antigiuridiche.
In conclusione, non possiamo che augurarci che l'emanazione della
Convenzione sia seguita dalla ratifica del maggior numero di paesi
possibile, al fine di limitare la presenza di reti "sporche" che
condividano contenuti illeciti con un numero di utenti sempre più maggiore
e inconsapevole che vengono a ritrovarsi in quella che oserei definire una
"piazza" virtualmente mondiale ma dove avvengono scambi tutt'altro che
virtuali.
Dott. Walter Paolicelli
|